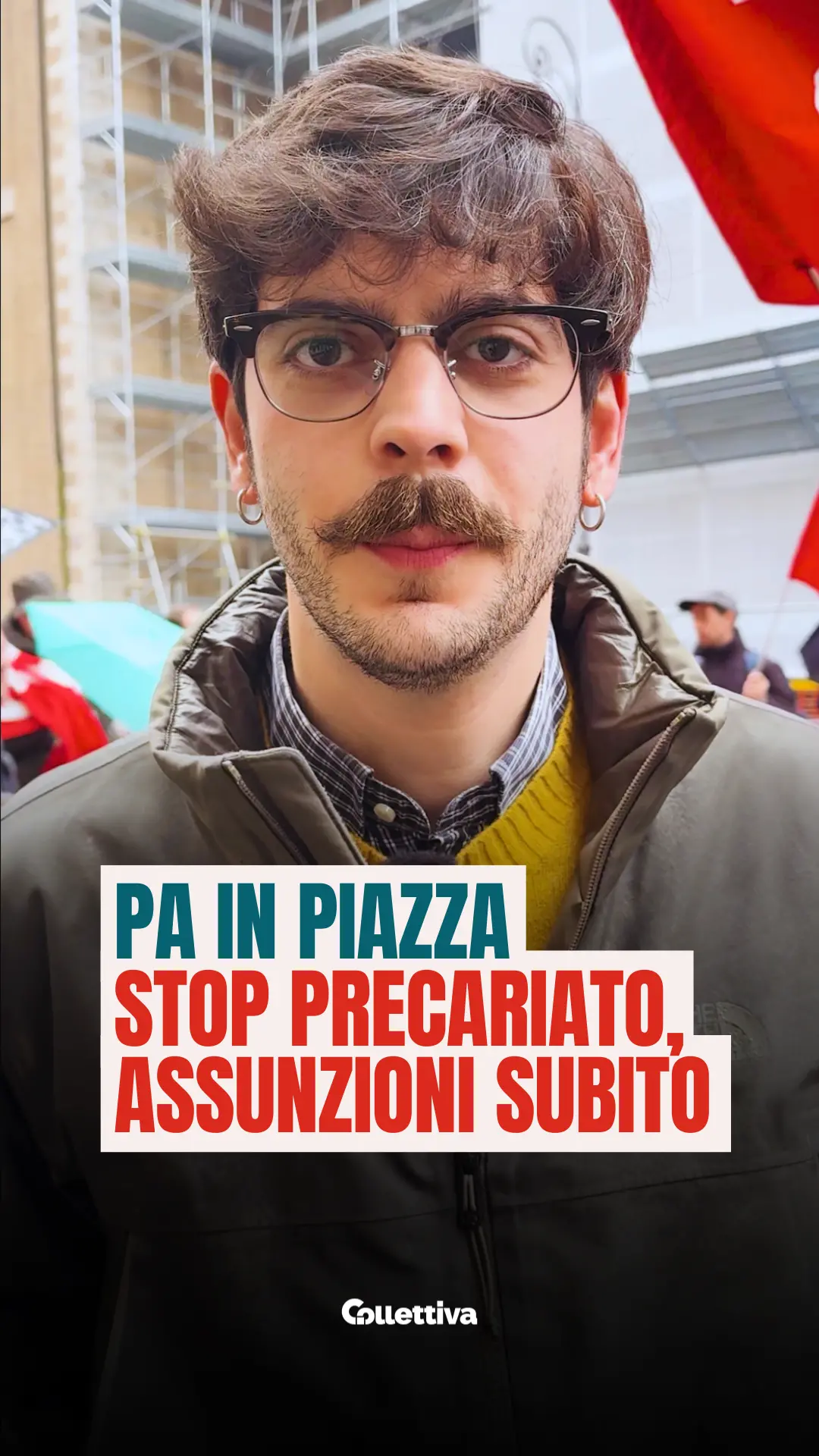PHOTO
Il divieto, introdotto dall’art. 1, comma 16, della legge n. 335/1995, di integrare al minimo le pensioni interamente calcolate con il sistema contributivo ha rappresentato, sin dall’origine, uno degli aspetti più critici della riforma previdenziale del 1995. Si trattava di una scelta normativa netta, che ha messo a dura prova il delicato equilibrio tra i principi di solidarietà e di corrispettività su cui si fonda il nostro sistema previdenziale. Per lungo tempo, tuttavia, gli effetti di questa esclusione sono rimasti attenuati, anche grazie alla persistenza del sistema di calcolo “pro quota” (sistema misto), che ha consentito a molti assicurati di conservare una componente retributiva sufficiente ad attivare l’integrazione al minimo.
Con il passare degli anni e il consolidarsi delle carriere interamente contributive, i nodi sono però venuti al pettine. La portata reale di quel divieto ha cominciato a manifestarsi in tutta la sua rigidità, evidenziando effetti distorsivi e discriminatori, soprattutto a danno dei lavoratori con percorsi professionali discontinui o economicamente deboli.
È stato in particolare nel momento in cui hanno iniziato a essere liquidati assegni ordinari di invalidità interamente contributivi - basati su almeno cinque anni di contribuzione e corredati dai requisiti medicolegali e reddituali - ma di importo così esiguo da risultare addirittura inferiore a quello delle provvidenze assistenziali per l’invalidità civile, che è emersa con forza l’irrazionalità del sistema.
È in questa fase che gli effetti concreti della norma si sono pienamente rivelati, alimentando una crescente attenzione critica da parte dei pensionati e delle loro organizzazioni. Ne è seguita una moltiplicazione delle iniziative giudiziarie, finalizzate a sollecitare un intervento correttivo nel rispetto dei principi costituzionali di adeguatezza e non discriminazione.
L’approccio iniziale al contenzioso, sostenuto con convinzione anche dal Patronato INCA, si fondava su un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina, basata sulla tesi dell’ultrattività dell’art. 1, comma 3, della legge n. 222/1984. Secondo questa impostazione, la norma - specificamente rivolta a garantire l’integrazione al minimo dell’assegno ordinario di invalidità - avrebbe conservato valore di disposizione speciale anche dopo il 1995, rimanendo estranea al divieto previsto dalla riforma, in quanto priva di qualsiasi riferimento al sistema di calcolo, retributivo o contributivo. Ne derivava che il divieto introdotto dalla legge n. 335/1995 dovesse ritenersi limitato alle “pensioni” propriamente dette, escludendo l’assegno ordinario di invalidità per via delle sue peculiarità: temporaneità, assenza di reversibilità e funzione vicaria.
Questa linea interpretativa ha trovato conferma in diverse pronunce di merito, tra cui quelle delle Corti d’appello di Bologna e Firenze, che hanno riconosciuto il diritto all’integrazione al minimo anche in presenza di assegni ordinari di invalidità liquidati con il solo metodo contributivo.
I giudizi di legittimità promossi dall’INPS, cui hanno resistito i titolari degli assegni - spesso con l’assistenza dell’INCA - hanno avuto anche l’effetto di sensibilizzare la Sezione lavoro della Corte di cassazione sulla rilevanza della questione. Dopo aver escluso la praticabilità di una lettura costituzionalmente orientata del dato normativo, in considerazione del tenore letterale inequivoco dell’art. 1, comma 16, della legge n. 335/1995, i giudici di legittimità hanno ritenuto necessario sollecitare un intervento chiarificatore. Da qui la doppia via della rimessione: alla Corte di Giustizia dell’Unione europea (nella causa Foca c. INPS, su cui la Commissione ha già espresso parere favorevole) e alla Corte costituzionale italiana, con l’ordinanza n. 206 del 2024, che ha dato luogo alla sentenza n. 94/2025, di cui si discute in questi giorni.
La Corte costituzionale, nella sua decisione, ha messo in rilievo la funzione peculiare dell’assegno ordinario di invalidità, istituto che si colloca a cavallo tra previdenza e assistenza, e al quale è stata riconosciuta natura “mista”. Sottolineando che la tutela costituzionale impone di garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita, indipendentemente dal sistema di calcolo adottato, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, della legge n. 335/1995, nella parte in cui esclude l’integrazione al minimo per l’assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo.
La pronuncia, pur espressamente limitata all’AOI, restituisce voce all’integrazione al minimo all’interno del sistema contributivo, affermando con chiarezza che l’esclusione automatica è incostituzionale quando riguarda prestazioni che, per la loro funzione e struttura, rischiano di tradursi in erogazioni simboliche e inadeguate.
Pur riconoscendo che il giudizio è circoscritto al solo assegno ordinario di invalidità, la sentenza si presta ad essere letta come un segnale forte di apertura verso una possibile reviviscenza mirata e selettiva dell’integrazione al minimo anche nel regime contributivo. In prospettiva, infatti, potrebbero risultare coinvolte altre prestazioni previdenziali - come le pensioni derivanti da carriere frammentate - che condividano analoghe criticità di insufficienza rispetto ai bisogni tutelati dall’art. 38, secondo comma, della Costituzione.
Si tratta di una pronuncia importante, che rappresenta una fondamentale affermazione del principio costituzionale di adeguatezza e un riconoscimento del ruolo redistributivo della previdenza pubblica. Si tratta di un risultato anche dell’azione sindacale che, come CGIL, abbiamo denunciato con forza negli anni, anche ai tavoli di confronto, legata anche all’esigenza di costruire una pensione di garanzia per tutti coloro che sono destinatari del sistema contributivo. È un passaggio che restituisce dignità e giustizia a lavoratrici e lavoratori discontinui, precari o colpiti da invalidità, e che riafferma il principio che nessuno può ricevere trattamenti inferiori alle prestazioni assistenziali pur avendo versato contributi previdenziali.
In questa chiave, il divieto generalizzato di integrazione al minimo previsto dall’art. 1, comma 16, della legge n. 335/1995 non può dirsi intangibile. La Corte ha infatti ribadito che la garanzia dei mezzi adeguati di sussistenza non può essere sacrificata in nome di una logica contributiva rigida, soprattutto quando il risultato è quello di liquidare trattamenti previdenziali inferiori, in termini assoluti, persino alle provvidenze assistenziali.
La sentenza si inserisce in un momento in cui si avverte la necessità di ridefinire i confini della protezione sociale per le generazioni più deboli del mercato del lavoro. Il principio affermato dalla Corte rappresenta un argine importante contro la riduzione della previdenza pubblica a mero calcolo individuale e ribadisce l’urgenza di riforme che tengano conto delle reali condizioni delle persone e non solo dell’equilibrio finanziario dei conti pubblici. Questo equilibrio, pur fondamentale, non può prescindere da una giusta redistribuzione delle risorse, che deve essere garantita anche attraverso il ricorso alla fiscalità generale, nel rispetto pieno del principio di progressività, così come sancito dalla Costituzione.
Infine, va sottolineato l’equilibrio con cui la Corte ha definito gli effetti temporali della propria pronuncia: in ossequio al principio di sostenibilità del sistema previdenziale, la dichiarazione di illegittimità costituzionale opera solo per il futuro, evitando di compromettere retroattivamente i conti pubblici e lasciando al legislatore il compito di adottare eventuali soluzioni di sistema.
Se oggi la pronuncia della Corte costituzionale si limita all’assegno ordinario di invalidità, nulla esclude che domani essa possa costituire il paradigma di riferimento per valutare la legittimità costituzionale di altri trattamenti previdenziali interamente contributivi, laddove presentino caratteristiche tali da renderli strutturalmente inadeguati a garantire un livello minimo di protezione conforme ai principi dell’art. 38 della Costituzione. Con questa sentenza, la Corte ha affermato un principio destinato a segnare un punto fermo: la previdenza non può essere ridotta a sola matematica contributiva, ma deve restare ancorata ai valori costituzionali di adeguatezza e parità di trattamento.
È inoltre necessario che l’INPS applichi tempestivamente la sentenza, garantendo la piena informazione e tutela alle lavoratrici e ai lavoratori interessati, anche, in relazione ad altre prestazioni di analoga natura, come la pensione di inabilità.